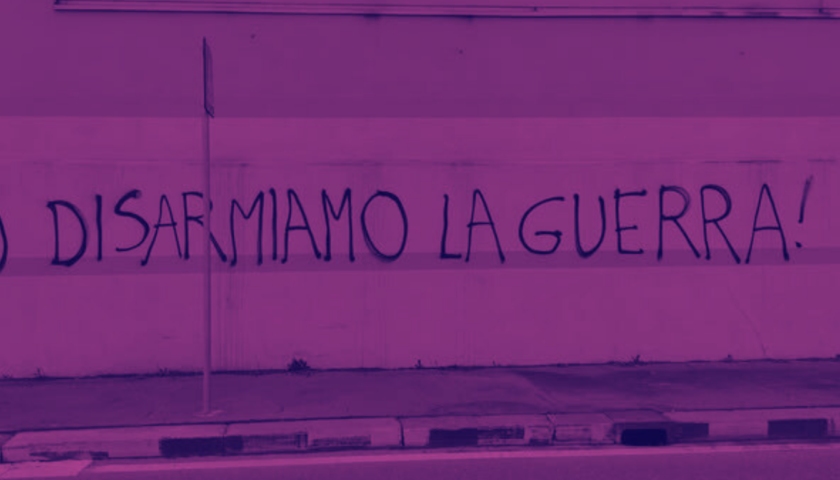La denigrazione può assurgere alle vette dell’arte o ai bassifondi della diffamazione, se non della calunnia, a seconda di chi e come la maneggia. Da qualche tempo essa si affolla anche nella storiografia dei movimenti operai, socialisti e anarchici. Non parlo di stroncature critiche e documentate, che queste hanno sempre costituito fonte primaria di polemica politica e di dibattito storiografico, ma di veri e propri attacchi alla reputazione dei militanti, afferenti a “motivi oscuri” o a “passioni mentali” ben difficilmente decifrabili. Ancor più odiosa, quando essi provengono da “storici” che si pretendono “indipendenti” e che si dilettano nel competere con gli storici accademici nello sfornare “scoop sensazionali”, alieni da contesti storico-politici e di ricerca, nell’intento di acquisire quel tantino di fama di cui rimarrà, purtroppo, traccia edulcorata nei dizionari elettronici anche dopo che la “spazzatura della storia” ne avrà fatto rapida giustizia.
È di quel genere il libro (un vero volume di ben 364 pagine) apparso nel luglio 2020, in cui fin dal titolo si denigra la figura e l’opera di Bruno Misefari (Giuseppe Tripodi, L’invenzione del ribelle. Vita tortuosa di Bruno Misefari, cosiddetto “anarchico di Calabria”). L’autore, incompetente in materia di storia dell’anarchismo (si vedano, a riprova, gli incredibili strafalcioni che punteggiano qua e là il testo), “presume”, sulla base di documentazione assai limitata – che erroneamente ritiene sia l’unica esistente e utilizzabile –, di poter stravolgere il mito o la leggenda che è valsa a Misefari il titolo onorifico di “anarchico di Calabria”. Ora, che sia un’operazione utile e addirittura indispensabile demolire tale mito o leggenda, e contestare quel titolo (in nome … di che ? di una presunta purezza dell’anarchismo? di una supposta verità storica? della costruzione narcisistica di una propria identità di storico? o di un “tradimento” politico-esistenziale comprensivo di ripudio del proprio e altrui passato?), è quanto meno dubbio.
Ma che lo si faccia con tanta sicumera e additando il povero Misefari come agente anziché vittima del fascismo, non può che indignarmi. Passi l’ignoranza sulla formazione anarchica di Misefari; passi l’inconsistenza documentaria – che alimenta impudiche illazioni – sulla sua scelta antimilitarista prima, durante e dopo la Grande Guerra; passi pure l’incomprensione sull’attività scientifica e imprenditoriale svolta da Misefari – che ricevette in parte l’appoggio delle alte sfere dello Stato, senza ch’egli dovette mai sconfessare le sue idee politiche (non giurò fedeltà al regime in nessuna università calabrese o padovana!), anzi conducendolo sulla soglia, oltrepassata, del confino di polizia, e comunque sempre con la minaccia dell’indigenza e dell’esilio; passi l’affidarsi senza riserve alle fonti di polizia (specialmente al CPC e là dove fa più comodo), passi il cinismo polemico nei confronti dei pochi momenti di umana debolezza che anche Misefari e famiglia ebbero nella loro vita.
Ma non ci va proprio giù che sulla base di una semplice dichiarazione, tra l’altro notissima – di quelle che decine di militanti antifascisti, per costrizione o sotterfugio, inviavano talora direttamente a Mussolini -, si costruisca una piramide di infamie su uno dei pochi che mai davvero tradì e se ne ricerchino gli antecedenti nella vita passata, nella sua militanza e nel suo modo di declinare l’anarchismo. Quella dichiarazione-verbale, redatta dal vice questore Guido Leto e sottoscritta da Misefari – alla quale d’altronde gli stessi organi centrali e periferici di polizia non prestarono eccessiva fede –, era parte di una più vasta corrispondenza col Ministero dell’Interno-affari Civili che Misefari aveva intrattenuto in qualità di industriale del vetro (in essa non vi è altro di cui potesse vergognarsi). Misefari, piegato dagli ostacoli frapposti a livello locale alla sua impresa scientifica e imprenditoriale, dalle sofferenze personali e dei famigliari (che le amplificheranno e forse distorceranno nel ricordo, come di solito avviene, molti anni dopo), vi annotava che “fin dal 1923 non esplica più attività politica e ciò, oltreché per ragioni attinenti alla sua professione, anche perché quale militante delle vecchie file del sindacalismo, ha sentito di stare in benevole attesa dello sviluppo del programma sindacalista e cooperativo progettato dal Governo”.
Quella firma, che potremmo considerare “estorta” (la “militanza antifascista attiva” di Misefari, ad esempio, è documentabile fino al 1926) o parte di una strategia di “occultamento” che impiegarono con successo altre forze antifasciste (comunisti, azionisti, qualche anarchico e diversi massoni – e Misefari era pure massone!), testimonia certamente di un suo momento di debolezza ma non può interpretarsi affatto come una “piccola abiura (o grande a seconda dei punti di vista, perché, una volta immerso nell’acqua del regime, poco importava che uno fosse rimasto appena sotto la superficie o a un chilometro di profondità)”, come machiavellicamente insinua (e ricama per tutto il resto del libro) il Tripodi.
So che i compagni calabresi hanno scelto la strada del silenzio per non dare credito o contribuire allo spaccio del libro, ma io non sono dello stesso parere. A chi getta fango sulla nostra storia e sui nostri più sperimentati militanti, senza d’altronde possedere sufficiente spessore scientifico e la necessaria umiltà, non rimane che consigliare, se non di andare a zappare (come avrebbe fatto Paolo Schicchi, con intento altamente educativo ed umanitario), di cambiare perlomeno mestiere.
Natale Musarra
pubblicato su Sicilia Libertaria, n. 414, Aprile 2021